Il 2019 è l’anno dedicato al personaggio geniale di Leonardo da Vinci, considerato grandissimo artista, avveniristico scienziato ed inventore, uno degli esponenti più illustri del Rinascimento europeo. Quest’anno ricorrono i 500 anni dalla morte, avvenuta il 2 maggio 1519, per cui non solo in Italia e in Francia, dove Leonardo è vissuto per lungo tempo e morto, ma anche in tutta l’Europa sono state organizzate numerose iniziative per celebrare il suo genio. Si può cominciare naturalmente da Firenze, dove già dallo corso ottobre, nell’Aula Magliabechiana degli Uffizi è stata inaugurata la mostra “Il codice Leicester” di Leonardo da Vinci-L’Acqua microscopio della Natura, che ha riportato in Italia il prezioso manoscritto, in precedenza chiamato “Codice Hammer”, dopo l’esposizione del 1982. La suggestiva mostra si è avvalsa di un dispositivo multimediale molto innovativo, che ha dato la possibilità ai visitatori di sfogliare direttamente i singoli fogli su schermi digitali, con il conseguente accesso alla trascrizione dei testi ed alle molteplici informazioni sui temi trattati. L’esposizione ha dato la possibilità di poter ammirare spettacolari disegni originali, ricavati da alcune opere rare di Leonardo, come il Del moto et misura dell’acqua o il famoso Codice sul volo degli uccelli. Sempre nel capoluogo toscano si segnalano altre numerose iniziative: presso il Museo di Galileo nel mese di ottobre 2019 si terrà un convegno dal titolo “Leonardo, l’universo dei manoscritti”, una mostra intitolata “La Biblioteca di Leonardo”, da maggio a settembre 2019, e la mostra “Leonardo ed il moto perpetuo”, che si terrà nel maggio 2020, in collaborazione con l’Università di Londra. A Firenze sarà molto partecipata la mostra “Leonardo e Firenze” dal 25 marzo al 24 giugno 2019, ospitata nell’ambito della prestigiosa e suggestiva Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, nonchè la mostra “Leonardo e la botanica”, che si svolgerà dal 13 settembre al 15 dicembre 2019 presso l’ex refettorio della basilica di Santa Maria Novella. Numerose celebrazioni si avranno nel comune di Vinci, luogo di nascita di Leonardo, di cui la più importante sarà la mostra dal 15 aprile al 15 ottobre intitolata “Leonardo da Vinci. Alle origini del Genio”, che avrà come oggetto soprattutto il legame di Leonardo con la sua città natale e sugli stimoli che il paesaggio toscano offrì alla sua formazione di artista, tecnologo e scienziato.
Sono tante anche le iniziative che si svolgeranno a Roma, tra cui si segnala un’affascinante mostra dedicata a Leonardo da Vinci scienziato, che si terrà presso le Scuderie del Quirinale tra il mese di marzo ed agosto, nonchè l’altra, dello stesso livello di prestigio, che si terrà presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, denominata “Leonardo a Roma. Influenza ed eredità”. Ma una delle città italiane, dove sarà maggiormente festeggiato Leonardo nel corso del 2109, sarà Milano, dove il genio di Leonardo lasciò le testimonianze più importanti, dal famoso dipinto raffigurante “L’ultima cena” alle particolarissime invenzioni conservate presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, proprio a lui dedicato. A Milano le celebrazioni in onore di Leonardo avranno inizio il 2 maggio, giorno della sua morte, e termineranno nel gennaio 2020. Ci sono, tuttavia, già alcune iniziative in corso, come quella inaugurata nel luglio 2018 la “Leonardo da Vinci Parade”, rassegna organizzata dal Museo della Scienza e della Tecnologia che sta offrendo un percorso tra arte e scienza mediante l’esposizione dei modelli più rappresentativi delle macchine realizzate da Leonardo. Tale rassegna si concluderà il prossimo ottobre. Il 2 maggio sarà riaperta la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, dove sarà possibile ammirare le straordinarie tempere a tema naturalistico dipinte da Leonardo intorno al 1498, dopo tanti anni di restauri. Inoltre, nella Cappella Ducale dello stesso castello, dal 16 maggio al 18 agosto 2019 si terrà la Mostra Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza, per approfondire le relazioni iconografiche e stilistiche e al cultura figurativa di Leonardo e di altri maestri dell’epoca rinascimentale. In quest’ottica di retrospettiva storica, dal 2 maggio 2019 al 2 gennaio 2020, la Sala delle armi ospiterà un tragitto multimediale, che offrirà ai visitatori un viaggio multimediale nella Milano rinascimentale di Leonardo. E da maggio 2019 a gennaio 2020 la Biblioteca Ambrosiana organizzerà ben tre mostre, ispirate a diverse tematiche connesse con il genio di Leonardo: da maggio a giugno 2019, Il meglio del Codice atlantico. Leonardo ingegnere, architetto, scienziato; da luglio 2019 a settembre 2019, I disegni del Codice Atlantico del periodo francese; infine da ottobre 2019 a gennaio 2020, si ripeterà la stessa della primavera.
Non mancano altre importanti iniziative nelle altre città italiane e d’Europa, tra cui si segnala quella già in corso a Napoli presso la Cripta del Complesso Monumentale Vincenziano, in pieno Rione Sanità, una mostra interattiva sulla vita, le macchine e le opere di Leonardo. E’ d’obbligo ricordare che Leonardo da Vinci è morto in Francia, nella pittoresca città d’Amboise, presso uno dei più suggestivi castelli della Valle della Loira, mentre era ospite del re Francesco I. Il 500^ anniversario dalla sua morte potrebbe essere l’occasione per visitare una delle regioni più visitate della Francia e dell’intera Europa, appunto la Valle della Loira, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO.
Ma chi era davvero Leonardo da Vinci? Proviamo a parlare di questo straordinario personaggio, uno dei più grandi geni dell’umanità, impresa ardua, considerando la sua personalità poliedrica non facilmente sintetizzabile in una breve rassegna. Nel corso degli ultimi decenni sono stati sempre più numerosi gli esegeti e gli studiosi che hanno creduto di cogliere in alcuni dipinti del grande maestro toscano una simbologia occulta ed esoterica. Egli nacque a Vinci, un villaggio toscano alle porte di Firenze, nel 1452. Da giovinetto mostrava già spiccate qualità di sensibilità e di estro che lo portarono a farsi assumere come apprendista in una delle principali botteghe di Firenze, cioè quella del pittore e scultore Andrea Verrocchio. In una bottega così rinomata, il giovane Leonardo aveva molto da imparare e si inserì molto bene, mostrandosi degno di apprendere i segreti tecnici del lavoro in fonderia e delle più svariate lavorazioni dei metalli. Inoltre poteva esercitarsi a dipingere e a scolpire, studiando piante ed animali insoliti che poi avrebbe inserito nei suoi quadri ed impadronendosi progressivamente dell’ottica prospettica e dell’esatto utilizzo dei colori. La vastità dei suoi interessi e la profondità del suo genio creativo ci sono stati tramandati dai numerosi schizzi ed appunti lasciati dai suoi compagni ed ammiratori.
L’aspetto che maggiormente contraddistingue Leonardo è forse il fatto che lui non appartenesse alla cerchia dei dotti per professione, ma fosse un vero e proprio “artista fiorentino”, convinto che il suo compito fosse quello di esplorare il mondo visibile in maniera intensa ed accurata. Non vi era nulla del mondo circostante che non destasse la sua curiosità e a cui lui non cercasse di dare spiegazione tramite i suoi avveniristici esperimenti. Fu, insomma, uno scienziato eclettico che con disinvoltura passava dallo studio delle onde e delle correnti, all’osservazione prolungata sul volo degli insetti e degli uccelli, cercando di capire come potesse servirsene per creare “una macchina volante” e forse fu uno dei primi a concepire la possibilità concreta che l’uomo potesse padroneggiare le leggi dell’aerodinamica o conoscere a fondo la struttura del corpo umano. I suoi contemporanei lo considerarono un soggetto bizzarro e molto misterioso, troppo fuori dagli schemi del tipico intellettuale dell’epoca. Leonardo amava intrattenere il pubblico con giocattoli meccanici di sua invenzione e si dilettava ad inventare scenografie innovative e visionarie per gli spettacoli molte volte improvvisati. E’ anche probabile che affrontasse molte problematiche soltanto per la sua insaziabile sete di conoscenza e che, una volta che avesse risolto per uso personale un problema, se ne disinteressasse, considerata la vastissima estensione dei suoi interessi. Il genio creativo di Leonardo, unitamente ad una buona dose di sregolatezza, lo portò a manifestare in molte occasioni insofferenza nei confronti dei suoi mecenati, scegliendo deliberatamente di non portare a termine alcune opere che gli erano state commissionate. Anche i suoi continui spostamenti furono abbastanza disordinati, trasferendosi a rotazione da Firenze a Milano e da Milano a Firenze, poi al servizio dell’ambizioso avventuriero Cesare Borgia, di seguito a Roma ed infine alla corte di Francesco I, re di Francia, dove trovò una certa stabilità e morì nel 1519.
In relazione alle sue opere principali, come delineo nel mio libro “I miti- luci e ombre”, Editore Cavinato International 2018, in cui dedico un intero capitolo al genio di Leonardo, non si può che partire dal capolavoro de “L’ultima cena”, collocata sulla parete di una sala rettangolare che era utilizzata come refettorio dai frati del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Mai prima della rappresentazione di Leonardo, il sacro e leggendario episodio dell’ultima cena era apparso così prossimo a noi e a tal punto verosimile. Sembra quasi che un’altra sala sia stata aggiunta a quella dei frati e che contemporaneamente si svolga un altro evento conviviale. E non si sbagliava Leonardo, quando affermava che le opere d’arte devono essere sempre giudicate per la loro somiglianza al vero, o meglio per la loro somiglianza all’idea che si vuole rappresentare. Niente dell’opera di Leonardo può essere accostato alle scene tradizionali dell’Ultima Cena, dove gli apostoli erano raffigurati tutti in fila, seduti a tavola in maniera composta, con Giuda più discosto, mentre Cristo istituiva il sacramento dell’eucaristia. Leonardo, invece, cerca di risalire ai testi sacri, al momento apicale quando Gesù denuncia agli apostoli il tradimento di uno di loro, arrivando ad una rappresentazione “umana” e non “liturgica” come quella ricavata dai precedenti artisti. Pietro appare impetuoso, mentre si avvicina a Giovanni che siede vicino a Gesù, spingendo in avanti Giuda che appare isolato, pur non essendo in disparte fisicamente dagli altri, segno del particolarissimo, quanto sfortunato destino che lo attende a breve. Agli studiosi non sono di certo sfuggite le proporzioni geometriche e matematiche che Leonardo nel dipinto ha voluto offrire agli spettatori. La struttura della stanza e la posizione degli apostoli presenta un subliminale suggerimento numerologico, legato al rapporto 1:3 ed al rapporto 3:4, che sta ad indicare il rapporto tra il mondo divino e quello terrestre o sublunare. Non bisogna dimenticare che la formazione di Leonardo avvenne a Firenze, la città che tra Umanesimo e Rinascimento, era all’avanguardia negli studi ermetici, neoplatonici e pitagorici. Nella città toscana erano stati tradotti per la prima volta i testi ermetici, a ciò si aggiunge l’intensa attività del filosofo Marsilio Ficino, fondatore dell’Accademia neoplatonica. Non a caso lo stesso Leonardo, come testimonia il Vasari, fu sul punto di abbandonare la pittura nell’operazione di “quadratura del cerchio” che, secondo il pensiero ermetico, avrebbe permesso di portare il “cerchio del cielo al quadrato della terra”, con la strabiliante conseguenza di ottenere una “quintessenza perfetta”, rivelatrice della stessa creazione divina.
Hanno fatto molto discutere i tratti “femminei” di Giovanni raffigurato nel dipinto, soprattutto a seguito della diffusione del best seller di Don Brown, Il codice Da Vinci. In realtà non vi è alcuna prova certa che al posto di Giovanni sia rappresentata Maria Maddalena. Le interpretazioni in proposito sono molteplici, come quella che, facendo leva sull’ironia e sulla ben nota omosessualità di Leonardo, ritiene che l’apostolo Giovanni possa esser stato delineato in maniera volutamente ambigua, in quanto il genio fiorentino avrebbe voluto giocare sull’ambiguità della frase contenuta nei vangeli riferita appunto a Giovanni, come “l’apostolo che Egli amava”.
Vi è un’opera di Leonardo altrettanto famosa, forse considerata la più celebre del mondo, si tratta della “Monna LIsa”, più nota come “La Gioconda”. Chi ha osservato questo dipinto non può fare a meno di interrogarsi sul significato di quell’enigmatico sorriso. Alcuni elementi compresi nell’opera rappresentano motivi abbastanza ricorrenti nella pittura del sedicesimo secolo, come l’ampio e serpeggiante paesaggio sullo sfondo, la scelta della mezza figura vista di tre quarti, nonchè la posizione delle mani davanti al busto. Ma con Leonardo si ottiene una miscela di caratteri dall’incomparabile armonia, mediante la minuziosa rappresentazione dei dettagli ed il delicato gioco delle luci che rendono “sfumata” quella particolare ambientazione atmosferica. E sulla “Gioconda” si sono scatenate tantissime leggende, forse quella attualmente più popolare è derivata dal già citato romanzo di Dan Brown, secondo il quale, nel celebre dipinto, Leonardo avrebbe voluto nascondere le tracce per ritrovare il “Sacro Graal”. Da sempre si è cercato di intravedere nel famoso quadro di Leonardo segni misteriosi che volessero esprimere una conoscenza alternativa. Una delle rivelazioni più interessanti è stata la ricostruzione nel 2011 di Silvano Vinceti che ha reso nota la presenza negli occhi della Gioconda, delle lettere L, V o S nell’occhio destro delle lettere CE o forse una B all’interno dell’occhio sinistro. E’ stato anche riscontrato il numero 72 in uno degli archi del piccolo ponte situato sullo sfondo destro. Per il Vinceti, la “L” e la “S” potrebbero essere proprio le iniziali dello stesso artista, mentre il numero 72 starebbe ad indicare il suo pensiero filosofico, esoterico e religioso. Le sembianze della donna ritratta potrebbero rappresentare un compendio del pensiero ermetico, esprimendo il superamento della contrapposizione tra Venere celeste e Venere volgare, tra il temperamento angelico e quello demoniaco, tra la dimensione spirituale e quella sensuale, tra l’immanente ed il trascendente. Per alcuni studiosi la “S” nell’occhio della della donna raffigurata potrebbe essere un’allusione al suo giovane collaboratore, il Salai. Qualcuno afferma addirittura che la Gioconda sia un uomo travestito da donna o un burlesco autoritratto dello stesso Leonardo.
Infine, nella breve dissertazione sul genio-Leonardo, vorrei accennare al celebre disegno che raffigura “l’uomo vitruviano” che presenta molti simboli non solo di carattere matematico-geometrico, ma anche con risvolti esoterici. Leonardo conobbe l’opera di Vitruvio sulle proporzioni umane, quando fu tradotta in lingua volgare nel 1400 da Martini. L’artista fiorentino utilizzò le proporzioni umane di Vitruvio, mettendo l’uomo al centro e costruendo su di esso il cerchio ed il quadrato. Ciò sta a rappresentare che è l’uomo, con le sue proporzioni, a delineare i rapporti con cui sono costruite le forme geometriche che, poi, come in un processo circolare, vengono utilizzate dall’uomo stesso per creare ciò che vuole. La rappresentazione dell’uomo vitruviano implica che l’uomo, riuscendo a padroneggiare le leggi della natura, riesce a riprodurre opere con le stesse regole spontanee della natura. L’artista si eleva verso la divinità, perchè creando la sua arte, si sostituisce al “Creatore universale”, avendo acquisito i suoi stessi metodi.
SE VUOI SAPERNE DI PIU' SULLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E IL PERCORSO CHE PROPONE, TI INVITIAMO A CONSULTARE LE SEGUENTI SEZIONI:
Se vuoi saperne di più sulla nostra organizzazione e il percorso che propone, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni:
Puoi anche contattarci al seguente indirizzo: info@centrokuun.it.SE TI E' PIACIUTO L'ARTICOLO CONDIVIDILO SUL TUO SOCIAL PREFERITO
QUALCHE PICCOLO CONSIGLIO DI LETTURA


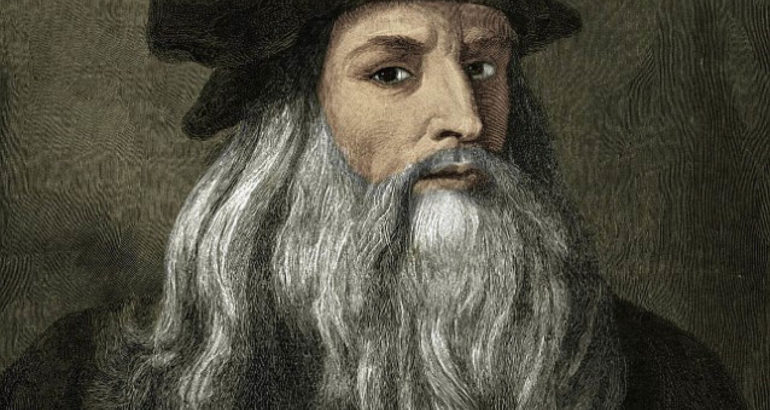








![L’Esaltazione dell’Imperfetto [R] L’Esaltazione dell’Imperfetto [R]](https://www.ilsapere.org/wp-content/uploads/2017/05/image-2-360x240.jpeg)




